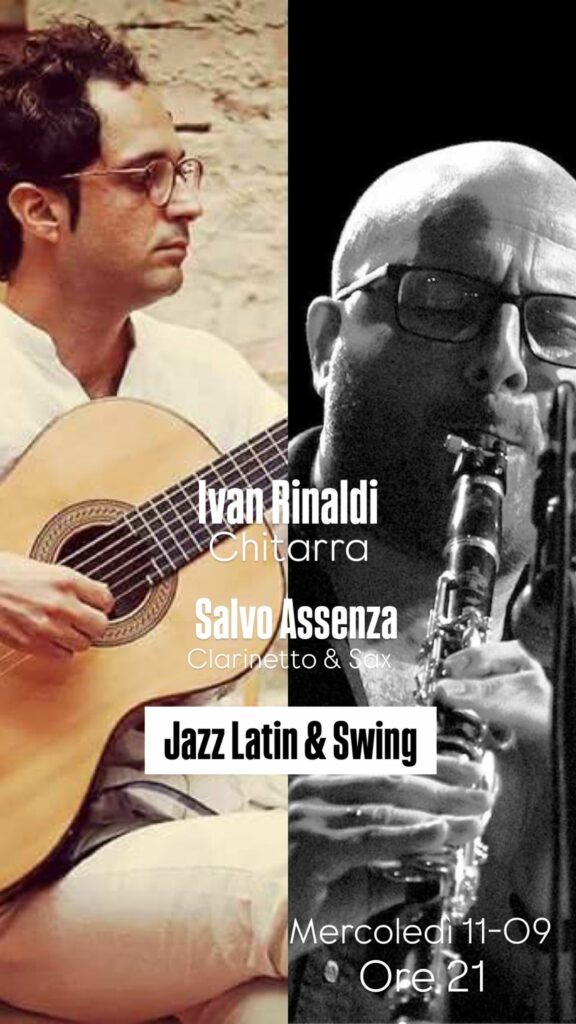Da quello di Ulisse al Grand Tour e più avanti nei secoli, il viaggio in Sicilia è un itinerario attraverso storia e cultura, disseminate lungo un territorio vestito da mito e leggende, fatti e parole, che si intrecciano alle vicende degli uomini di ogni tempo.
A riportarle alla luce con fascino affabulatorio dentro le mura del Castello di Milazzo, tra le Isole Eolie e l’Etna sullo sfondo, è il Maestro Nino Pracanica, artista e cantastorie, che incanta il pubblico dando voce alle maschere realizzate con la moglie Gina, pittrice e onnipresente compagna del sodalizio creativo.
Visitando il magnifico complesso monumentale – tra il Museo del Mare all’interno dell’ex chiesa del Bastione Santa Maria, l’antico Duomo seicentesco e lo spazio museale per reperti archeologici di varia epoca, e il Museo della Tonnara di Milazzo nell’ex Monastero delle Benedettine – lo si incontra nel Museo delle Favole, il laboratorio artistico che è insieme galleria di opere, palcoscenico teatrale e fucina di improvvisazione.
Alto e ieratico, come un indovino in grado di predire il futuro, proprio perché a lungo ha viaggiato nel passato, con orgoglio ottuagenario offre agli spettatori una narrazione sempre rinnovata, interpretando personaggi reali e fittizi dietro una maschera, raccontando il vissuto dei popoli, cancellando luoghi comuni e restituendo alla memoria quello che la modernità in fuga tende a portare via.
Raggiungiamo il Maestro, mentre in un francese gentile spiega a un gruppo di turisti la dignità del suono del marranzano, malevolmente associato ai racconti di mafia e a un’immagine della Sicilia parziale e non veritiera. Piuttosto osserva che la criminalità ha investito la regione dal tempo delle ruberie di Verre fino a quello dei briganti, citando Cicerone e pagine di storia, sorpreso di scoprire che i presenti non conoscano Madeleine Cavalier, l’archeologa e ricercatrice francese, compagna e collaboratrice di Luigi Bernabò Brea, fondatore del Museo Archeologico Regionale di Lipari. Lo scopo – come ripeterà anche al successivo pubblico di turisti italiani – è quello di recuperare le voci, i racconti e i suoni frammentati dall’immaginario collettivo, che si è imposto sull’intuizione e sull’elaborazione da parte del singolo. E ai bambini mostra che il buon marranzano, innanzitutto, è in grado di fare viaggiare i suoni fuori dalla pancia, e persino di riportarli indietro.
È un’operazione cui concorrono il ricorso a strumenti musicali di sua invenzione, a partire dall’inseparabile tamburello, sul quale le dita corrono veloci per scandire il ritmo favolistico, e altri arnesi a percussione, ispirati a modelli dell’antichità più remota; e soprattutto alle maschere teatrali in cuoio, legno, gesso e materiali di recupero, come frammenti di corda, pelle e tessuti, realizzate attraverso tecniche d’età egiziana e romana, al pari delle cornici e delle tele preparatorie ai dipinti della moglie.
Sul fondale di scena, ma anche sui ripiani del laboratorio teatrale del Castello, si susseguono numerose maschere di forme e dimensioni diverse, e lo stesso Maestro racconta di averne create molte altre, alcune ancora nella sua officina, altre ormai in giro per il mondo. Tra le opere, riconosciamo anche il ritratto di un sovrano normanno a cavallo e quello a colori della Sicilia, su un fondo di gesso bianchissimo. Delle maschere più suggestive, invece, quella di Polifemo conosce versioni contrapposte: una è drammatica e lo rappresenta accecato e sanguinante; l’altra è rivestita di tessuto rosso, acceso come la lava, e ne fa un personaggio astuto, al corrente degli effetti del vino, perché di uve, vigne e vigneti s’intende lui stesso, tanto da lasciare supporre di essere in grado di sfuggire agli inganni di Ulisse.
Da un racconto all’altro, Nino Pracanica mescola miti, leggende e storia, convocandone i protagonisti e ridipingendone le avventure con i colori della fantasia.
«Ho conosciuto molti personaggi e ancora li incontro» – dice – «Artisti, poeti, imperatori, filosofi, pensatori, cavalieri, uomini del passato» .
E cosa dicono?
«Mi insegnano la verità che si nasconde tra le parole. Ho parlato con Saffo, quando era triste, allontanata dai concittadini perché amava le donne anziché gli uomini. ”La vedi quella mela?” – mi ha detto, un giorno, mostrandomela su un albero – ”Sai perché non l’ha raccolta nessuno?” – ”Perché non l’hanno vista” – ”No, perché era troppo in alto e nessuno era in grado di raccoglierla”».
Chi viene al Castello ad ascoltare le sue storie?
«Ogni anno vengono qui scolaresche da tutta Italia, tanti ragazzi e bambini, ma tanti davvero, e ripartono con le mie favole in tasca. È un’emozione stare con loro. Poi ci sono i visitatori del Castello, che si affacciano timidamente all’ingresso del Museo. ”Entrate, è tutto gratuito, ma dovete aprirvi e non chiudervi” – dico a tutti. E poi c’è il pubblico degli eventi, quando mi invitano come ospite».
Quali storie racconta più spesso?
«Quelle dei paladini di Francia, ce ne sono più versioni. Io le interpreto dando voce diversa a ciascuno dei personaggi, facendo risaltare le emozioni dell’azione che si sta svolgendo. I bambini capiscono subito e mi seguono più dei grandi, perché la loro mente è libera dai pensieri; e possono viaggiare con la fantasia, che può farli volare e portare lontano. I grandi, invece, fanno fatica a usare la fantasia, devono pensare alle bollette» .
E quando scatta il momento magico?
«Basta dire ”C’era una volta un re…” e i bambini mi seguono immediatamente, ripetendo con me le stesse parole, anche con il suono della musica. Sanno distinguere le voci dei personaggi e interpretare le emozioni, come a teatro. A loro racconto la leggenda di Colapesce, che ci ricorda il legame con il mare e con la nostra terra di Sicilia. Quello che attraversa il mare e la terra, è tradizione, è la nostra storia. Non ce ne dovremmo dimenticare, invece …».
… invece?
«E invece della nostra lingua, ad esempio, un po’ ci siamo dimenticati, perché ne abbiamo imparata un’altra. Ed è quella che usiamo di più. Ma quanta letteratura e quanta poesia è stata scritta in siciliano? Parliamo più spesso di Verga e Pirandello, e meno di Nino Martoglio, che ha scritto tanto per il teatro, e pure versi di grande poesia: ”Bedda, cu fici a tia pinceva finu … ti fici li labbruzza di rubinu … lu pettu ti lu fici palumminu, li denti janchi e l’occhiu juculanu…” » .
È anche la lingua dei poeti del Duecento.
«Certamente, ed è nata alla corte di Federico II, con i poeti della Scuola Siciliana. C’era Iacopo da Lentini, con cui Federico giocava da bambino, e il Papa e quelli della Corte non volevano. ”Federico, vieni qui, lascia stare quel nero!” – gli dicevano. ”Quale nero? Quello è Iacopo, è amico mio” – rispondeva lui, perché non faceva differenze con gli stranieri, né di cultura, né di religione. C’era persino una donna, Nina da Messina, importantissima, una delle prime poetesse conosciute. E poi è successo che hanno tramandato le loro poesie, però cambiando le parole».
In che senso?
«Solo una di Stefano Protonotaro si è salvata nella versione originale della lingua siciliana, perché è successo, come ha detto Dante, che loro sono stati i primi a pensare a una lingua unica, superiore, non provinciale, ma poi i testi li hanno ricopiati i toscani e a noi sono arrivati rimaneggiati, pure quelli del grande maestro che fu Iacopo da Lentini. Quando mai un siciliano avrebbe scritto o detto ”Io m’aggio”?»
Poi i versi del sonetto duecentesco rivivono nella voce del Maestro, e la luce irradiata dal cielo azzurrissimo potrebbe essere quella di allora, o appena di qualche secolo dopo, all’ombra della cinta spagnola del Castello.
«Io m’aggio posto in core a Dio servire,
com’io potesse gire in paradiso,
al santo loco ch’aggio audito dire,
u’ si manten sollazzo, gioco e riso.
Sanza mia donna non vi voria gire,
quella c’ha blonda testa e claro viso,
ché sanza lei non poteria gaudere,
estando da la mia donna diviso.
Ma non lo dico a tale intendimento,
perch’io peccato ci volesse fare;
se non veder lo suo bel portamento
e lo bel viso e ’l morbido sguardare:
ché lo mi teria in gran consolamento,
veggendo la mia donna in ghiora stare.»
Intorno, l’estate brilla nel canto delle cicale, accompagnando l’antica scrittura d’amore. E con un amante che non vuole entrare in Paradiso senza la sua amata, la mente va al libretto d’opera di Cavalleria Rusticana e alla serenata di Turiddu a Lola: « … s’iddu muoru e vaju m’paradisu/si nun ce truovo a ttia, mancu ce trasu».
Maestro, non ci siamo inventati niente di nuovo, la scrittura d’amore risuona dello stesso desiderio.
«Certo, Iacopo scrive di un uomo che ama una donna, ma quello che gli importa è solo di averla accanto, di condividere la stessa gloria in Paradiso, la stessa felicità. È come fare qualcosa con gioia e coinvolgere il pubblico che viene ad ascoltare le mie favole al Castello. Conoscere è capire e non avere paura. Quella che racconto è Storia, ma io la dico a modo mio, perché così so che potrà viaggiare più lontano».